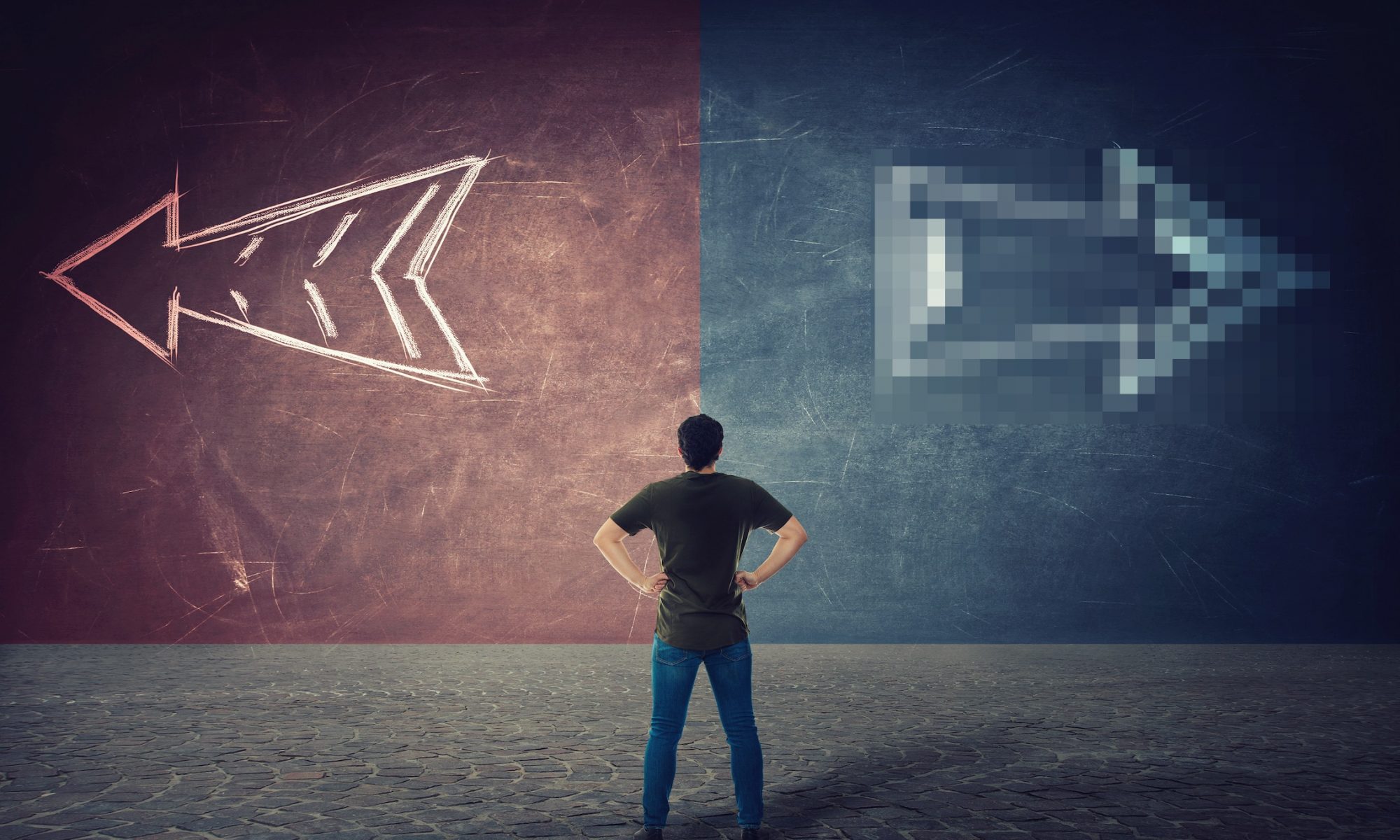Il mio editoriale per il Corriere della Sera-Corriere di Bologna
«Cavallo scosso». Di primo acchito la Destra partitica di Bologna è simile agli equini in corsa al Palio di Siena che hanno appena disarcionato il fantino e corrono solitari verso la metà, spinti più dalle urla e dalla paura della folla che per una pianificata azione di competizione ippica. In realtà questa fascinosa abusata metafora non rispetta completamente le condizioni in cui versa la destra bolognese, ed emiliano-romagnola in genere. Non ha perduto per un accidente della storia il proprio leader/fantino, semplicemente non lo ha allevato, ne è priva e perciò si affida al caso. Al fato, alla casualità, all’errore dell’avversario, a congiunture astrali che non sempre si verificano.
A tre mesi dalle elezioni amministrative ancora non è all’orizzonte nessun profilo di candidato semplicemente perché in questi anni la destra si è comodamente adagiata sulla condizione di opposizione, confidando in una redistribuzione dei consensi derivante dal crescere della popolarità di Berlusconi prima, del senatore di Locri dopo, e infine sperando nell’exploit di Meloni. Di cui in città esistono diversi epigoni e sostenitori, incapaci però di progettare – questo dice la realtà storica – una proposta alternativa al centro-sinistra, con cui hanno provato a convivere, talvolta in maniera consociativa, ma mai aprendo una sfida serrata, franca, programmata. Il 1999 fu un incidente nella storia della città – in più Guazzaloca non era di destra – e non si ripeterà nel breve, perché l’alternanza non si improvvisa, va costruita coltivando l’alternativa, di cui negli ultimi lustri non si è vista traccia. Un po’ come fece per anni il centro-sinistra a Milano che giungeva agli appuntamenti senza capo (né coda) e confidava che il candidato estratto quasi a sorte compisse il movimento divinatorio spalancando le porte del Municipio, prima di capire che fosse necessario gettare le basi per il cambiamento e intraprendesse il percorso di ascolto e costruzione della leadership con Pisapia. Sotto le Due Torri la destra non ha alcuna chance e lo dimostra il fatto che il candidato non sia ancora pronto non solo perché ci sono state le primarie del centro-sinistra, ma perché non ha nomi (e cognomi) autorevoli e competitivi da spendere che siano in grado di sfidare realmente Lepore. La candidata sfidante di Merola nel 2016 ha de facto lasciato Palazzo d’Accursio e non si è posta come guida dell’opposizione né in Consiglio né in città, tantomeno a capo della coalizione. Analogamente non è emerso nessun disegno complessivo di costruzione di progettualità, ma singoli che hanno talvolta criticato su aspetti puntuali l’amministrazione uscente ovvero hanno presidiato Bologna quali reggenti locali dei rispettivi referenti nazionali.
Abituati alle prebende padronali della destra conservatrice derivanti dalla guida del Cavaliere, il centro-destra locale non riesce a proporre un progetto realmente intraprendente, tale da mettere in discussione il PD. I rapporti di forza elettorali in campo lasciano poco spazio e residue velleitarie prospettive immediate, tanto da indurre ad un comprensibile attendismo sebbene infruttuoso. Tuttavia, per vincere in futuro la Destra dovrebbe iniziare a scavare sin da ora. Mettendo sul tavolo idee, proposte, e risposte, senza indulgere in tatticismo.
L’impasse in cui si trova per indolenza il centro-destra non è congiunturale, ma storico, cronicizzato. La sfida Lepore-Conti è stata solo un alibi, ché una forza sfidante avrebbe dovuto avere in carniere una contromossa matura da mesi, forse anni. Il candidato – chiunque – che arriverà nei prossimi giorni sarà comunque un ripiego, poiché non figlio di un progetto lungimirante, ma un cappello poggiato su una seggiola per segnare il posto. L’inezia della destra rende ineluttabile, e perciò negativa, l’egemonia del centro-sinistra/PD. L’assenza di competizione degenera e produce conseguenze negative per l’intera città; per il centro-sinistra che non si sfidato si crogiola, vanesio talvolta, egocentrico, e per il centro-destra che non in grado di con-vincere declama diversità, si autocommisera, ma rimane trincerato nella ridotta personalistica di pochi peones locali. Orfana del Cavaliere, la destra di Bologna dovrebbe quantomeno tentare almeno a racimolare un fantino. Proponendogli un percorso.